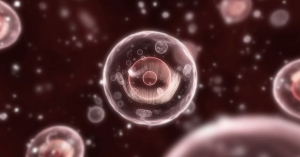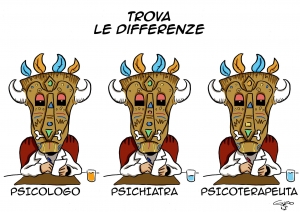Visualizza articoli per tag: Psicologo Palermo
In questi ultimi mesi del 2018 si è parlato molto di counseling e nel momento in cui scrivo la polemica è ancora aperta. Non voglio tediarvi con tutti i passaggi burocratici, con le iniziative di alcuni Ordini degli Psicologi regionali contro le iniziative e alcune dichiarazioni ambigue da parte dell’Ordine Nazionale degli Psicologi (CNOP), non vi annoierò scrivendo di leggi o di altro. Quando scrivo gli articoli per questo “blog” ho sempre in mente i potenziali lettori, persone che magari accedono a queste pagine inserendo nel motore di ricerca di Google termini come “psicologo a Palermo”, “psicoterapeuta”, “ansia”, “attacchi di panico”, “depressione” o altro. Probabilmente tra queste persone, alcune in questo momento della loro vita stanno attraversando un momento di malessere psicologico e cercano qualcuno o qualcosa che possa aiutarli ad uscirne. Alcune di queste persone sono probabilmente disorientate, non conoscono la differenza tra uno psichiatra, uno psicoterapeuta ed uno psicologo e, non avendo chiaro quale sia il loro malessere, non hanno chiaro quale sia il professionista più adatto a loro. Nel blog sono già presenti articoli che parlano della differenza tra le tre professioni scritte sopra, o articoli sulle leggi che regolamentano la professione di psicologo e di psicoterapeuta, o ancora articoli che spiegano ogni articolo del codice deontologico e le sue implicazioni teoriche e pratiche. Vi rimando a questi articoli se siete interessati ad approfondire questi aspetti.
In questo articolo invece vorrei scrivere del counselling e dei rischi che si corrono quando a praticarlo è una persona non preparata e non autorizzata.
Se cercate su wikipedia la parola “counseling” le prime tre righe che incontrerete saranno queste:
“Il termine counseling (o anche counselling in inglese britannico) indica un'attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del soggetto, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. Si occupa di problemi non specifici (prendere decisioni, miglioramento delle relazioni interpersonali) e contestualmente circoscritti (famiglia, scuola, lavoro). In Italia tale attività è svolta dallo psicologo, come atto tipico della propria professione”.
In Italia tale attività è svolta dallo psicologo… questa a mio avviso è la frase più importante, perché il counseling è un atto tipico della nostra professione. C’è la falsa credenza che la nostra professione si basi su un ascolto (più o meno attento) delle problematiche portate dall’altro e sull’elargizione di una serie di consigli sul “cosa fare” e sul “come farlo” affinché le cose possano sistemarsi. C’è la falsa credenza che “tutti siamo un po’ psicologi”… Nulla di più sbagliato. La nostra professione prevede una serie di competenze (attive e passive) che si acquisiscono in svariati anni di studio, tirocinio, seminari, congressi e tanto altro. Per definirsi psicologo bisogna superare un esame di stato al quale si accede solo con una laurea quinquennale in psicologia ed un anno di tirocinio professionalizzante. Per diventare uno psicoterapeuta bisogna aggiungere a quanto scritto prima altri quattro anni di una scuola di specializzazione riconosciuta dal ministero e, molto spesso, una psicoterapia personale. Amici, familiari, sacerdoti, vecchi saggi, guru, sciamani e altre figure danno e daranno consigli basati non su competenze scientifiche, ma su esperienze e vissuti propri che a volte non fanno altro che danneggiare l’altro colpevolizzandolo o sminuendo il problema. A tutte queste figure mancano tutta una serie di competenze (quella diagnostica in primis) che permettono di inquadrare veramente il malessere all’interno di un sistema familiare e sociale che chiunque di noi si porta dentro e dal quale chiunque di noi è attraversato. Lo psicologo competente non consiglia, lo psicologo competente apre nuovi scenari, nuovi punti di vista e lascia sempre libero il suo paziente di agire come vuole e come può.
Altra frase presa da wikipedia: “Il counseling è una professione non organizzata, ovvero priva di una legge istitutiva e di un ordine professionale. A seguito del varo da parte del parlamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" il counseling è stato inserito tra le professioni intellettuali, per esercitare le quali non è necessario seguire alcun iter specifico. La normativa lascia al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente intraprendendo un percorso privato di certificazione professionale presso un'associazione professionale di categoria o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria. Da un punto di vista pubblicistico chiunque può dichiararsi "counselor" senza alcun obbligo di formazione specifica”.
Non è necessario seguire alcun iter specifico… chiunque può dichiararsi “counselor”… personalmente mi vengono i brividi. Pensare che chiunque può aprire la porta di uno studio e accogliere una persona che sta male, giocando con la salute di questa persona, avendo la presunzione di “poterla aiutare” e di “saperla aiutare” è un qualcosa che mi lascia perplesso.
Ad oggi, con un corso di appena qualche week-end al mese per due anni (o anche meno) si diventa counselor… a mio avviso non basta per prendersi cura di qualcosa di così delicato come la nostra psiche, le nostre emozioni, la nostra capacità di stare al mondo, di amare, di lavorare, di avere una vita relazionale e sessuale soddisfacenti. Una recente campagna contro l’abuso della professione di psicologo, promossa dall’associazione “AltraPsicologia” recitava così: “non mettere la tua testa nelle mani del primo che capita”.
Ovviamente le associazioni di counselor affermano di prendersi cura di problemi generici, di non occuparsi di psicopatologia e di mantenersi a distanza da aree che, legalmente, non gli competono. Questo può essere vero, non penso che i counselor siano truffatori o cattive persone. Solo mi chiedo come facciano ad accorgersi, quando hanno un cliente davanti, che questi abbia o non abbia una patologia sottostante al problema che porta. Ad esempio, come fanno a capire che la persona che si rivolge a loro lamentando una “sfortuna” nelle relazioni sociali non abbia in realtà un disturbo di personalità borderline che lo porta a fare allontanare inconsciamente tutti quelli che gli si avvicinano? Con quali competenze riescono a differenziare una semplice difficoltà momentanea (che tutti noi possiamo avere) da un qualcosa di più profondo che causa quella difficoltà? Il problema a mio avviso non sta nell’onestà intellettuale di chi svolge un lavoro, ma nelle competenze realmente acquisite che gli premettono di svolgere quel lavoro al meglio.
Per questi motivi io, personalmente, non andrei mai da un counselor. Certo, probabilmente costa meno di uno psicoterapeuta, probabilmente il percorso proposto sarà anche più breve, ma i risultati saranno (se ci saranno) sicuramente inferiori sia in qualità sia in stabilità e durata a lungo termine. La nostra salute mentale è preziosissima, non sottovalutiamola. Quando chiedete aiuto controllate sempre che la persona che avete contattato abbia le credenziali giuste: iscrizione all’albo professionale, abilitazione all’esercizio della psicoterapia (qualora vogliate intraprendere un percorso di psicoterapia), assicurazione RC professionale, possibilità di fatturare le prestazioni. Così facendo vi proteggete dal punto di vista legale, e avrete più fiducia sul fatto che il professionista che vi sta accogliendo sia preparato e autorizzato.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Tra le malattie a minaccia per la vita, il cancro si pone come evento tra i più traumatici e stressanti con il quale chi ne è colpito deve confrontarsi. Nonostante i progressi della medicina in ambito oncologico, infatti, il vissuto soggettivo del cancro e l’interpretazione individuale e sociale di questa malattia restano quelli di un processo insidioso e incontrollabile, che invade, trasforma e, lentamente, porta alla morte.
Il cancro, indipendentemente dai contesti culturali, è considerato in ogni caso la malattia più temuta in assoluto.
Indubbiamente, poche altre malattie hanno così evidenti conseguenze per la persona ammalata, minacciando e interferendo su tutte le dimensioni su cui si fonda l’unicità dell’essere umano: la dimensione fisica, la dimensione psicologica, la dimensione spirituale ed esistenziale e la dimensione relazionale.
A livello fisico il corpo rappresenta il primo nucleo dell’identità personale che viene colpito. Il cancro, portando in primo piano la morte come realtà concreta, rende evidente, spesso in maniera improvvisa e imprevedibile, la finitezza della vita. Gli effetti della malattia e delle terapie, quali le mutilazioni fisiche, il dolore, la nausea e il vomito, la perdita di capelli o l’astenia, determinano modificazioni violente della propria immagine corporea. Tali cambiamenti possono comportare difficoltà nella conduzione della propria vita quotidiana, a causa delle limitazioni del paziente, della necessità di aiuto, della perdita parziale o totale della propria autonomia e della conseguente dipendenza dagli altri.
È evidente che tutto ciò si associa a conseguenze importanti sul piano psicologico, data l’inscindibilità, come esseri umani, della sfera biologica ed emozionale. Le reazioni emotive e le difese psichiche messe in atto dal paziente costituiscono un’area fondamentale per la comprensione del significato della malattia.
Strettamente correlata alla dimensione emozionale è la dimensione spirituale che coinvolge le parti più profonde dell’essere e dell’essenza di ciascuno di noi. È evidente che la spiritualità include non solo la fede ed il proprio credo religioso, ma il senso stesso che si da alla vita e all’esistenza, il significato del tempo e del destino.
Intersecato con queste dimensioni, il livello relazionale descrive e denota gli aspetti relativi al nostro essere individui concepibili e riconoscibili solo in un contesto comunicativo e relazionale. Il nostro senso di appartenenza ai sistemi micro-sociali (famiglia, amici) e macro-sociali (lavoro, comunità, politica) viene minacciato e colpito dalla diagnosi di cancro. Le modifiche relative a come ci si percepisce e a come dagli altri si è, a propria volta, percepiti, minacciano il mantenimento di sentimenti di integrazione e appartenenza, a scapito di sentimenti di abbandono, solitudine ed emarginazione che emergono in maniera tumultuosa e disumanizzante.
Risulta chiaro da quanto scritto come sia l’assistenza alla persona colpita dal cancro sia i percorsi di cura debbano articolarsi prendendo in considerazione, in maniera globale, tutte le dimensioni dell’esistenza.
Il percorso di malattia-cancro è posto all’interno di un continuum che va dalla comparsa dei primi sintomi di sospetto alla guarigione o alla fase di terminalità. Secondo una lettura evolutiva è possibile decodificare e interpretare l’ammalarsi di cancro, approfondendo la comprensione delle implicazioni psicosociali della malattia secondo le singole fasi del percorso che la persona sta affrontando.
In altre parole, possiamo descrivere le conseguenze psicosociali della malattia, differenziando una fase di allarme pre-diagnostico, relativa al periodo della comparsa dei primi sintomi e del sospetto della malattia, una fase acuta, che coinvolge il periodo di crisi determinata dalla diagnosi, e una fase elaborativa, più prolungata, che riguarda il periodo successivo, caratterizzato dal graduale e progressivo riassestamento alla nuova situazione. È evidente che a questa fase possono far seguito ulteriori fasi a seconda dell’evoluzione e dell’esito della malattia, rappresentate rispettivamente dalla guarigione o dalla ricorrenza o recidiva di malattia fino alla morte. Vediamo queste fasi nel dettaglio.
La fase pre-diagnostica rappresenta un momento importante, caratterizzato da emozioni intense e drammatiche. La scoperta di sintomi in sedi o organi noti per il rischio di neoplasia determina una reazione di allarme nei confronti della quale le persone reagiscono attraverso modalità diverse. Alcune variabili entrano in gioco nell’influenzare questo delicato momento: il momento della vita in cui questi sintomi compaiono, la personalità, il bagaglio di esperienze personali di malattia, lo stile individuale con cui l’attenzione o i comportamenti vengono rivolti alla salute.
La più frequente e comprensibile reazione osservabile è quella di allarme, caratterizzata da un elevato senso di preoccupazione e di incertezza rispetto ai significati del sintomo. È questo dubbio atroce, questo pre-sentimento o timore più o meno evidente che spinge, nella maggior parte dei casi, a rivolgersi al proprio medico per iniziare gli accertamenti più idonei. In molte circostanze prevale una reazione di ansia controllabile, mediata dalla tendenza del paziente a razionalizzare la situazione e ad attendere l’esito degli esami diagnostici. In altre circostanze prevale un atteggiamento pessimista in cui i pensieri sono polarizzati dai propri sintomi, vissuti con una certezza intima che stiano ad indicare la presenza del cancro. Gli esami diagnostici risultano quasi sempre stressanti e densi di tensione, ma è soprattutto il periodo dell’attesa dell’esito a risultare estremamente pesante sul piano emotivo. In alcune circostanze invece può accadere che l’inondazione dell’ansia sia talmente elevata che scattino meccanismi di minimizzazione o negazione del significato dei sintomi che la persona ha scoperto e che, quindi, per lungo tempo non vengono portati all’attenzione medica. Nel caso in cui sia, in effetti, presente un processo neoplastico, ciò può portare ad un grave e talvolta irrimediabile ritardo della diagnosi.
Quando i sospetti si trasformano in realtà, si determina la fase di crisi nel senso specifico del termine. Il significato della malattia in tutti i suoi risvolti drammatici invade e travolge la persona, sommergendola in maniera dirompente. Il pattern più tipico della risposta umana a questo tipo di evento è caratterizzato dalla sequenza di reazioni emozionali e comportamentali in cui sembrano succedersi diversi momenti, noti come fase dello shock (caratterizzato da incredulità e protesta per l’evento accaduto, fase di espressione di sintomi emozionali acuti (caratterizzata da stati fluttuanti in cui si alternano rabbia, disperazione, angoscia e paura), fase depressiva (in cui prevale una condizione di demoralizzazione e depressione) e fase della riorganizzazione (in cui si tenta di ristabilire un equilibrio e un riadattamento rispetto alla perdita subita). In tale sequenza di risposte è evidente il bisogno di riportare nella realtà quanto è stato perduto. Nell’impossibilità di riappropriarsi di ciò che non vi è più, si delinea la necessità di adattarsi alla nuova situazione.
Nelle fasi successive, il dover convivere con la malattia e con quanto questa ha determinato o sta determinando nella vita assume un valore centrale. In questa fase, detta del riorientamento, si assiste alla ricerca di significati nuovi da dare sia alla malattia come evento esistenziale sia alla propria esistenza nel suo insieme. Alcuni considerano questa fase come quella del “limbo”, dell’attesa di una definizione più precisa e di una certezza di essere salvi. Questa condizione viene sostenuta da molti pazienti e collegata al tempo che passa, generalmente racchiuso in una cornice definita: cinque anni. Se si resiste per questo periodo la malattia sarà definitivamente sconfitta (e, nell’immaginario, non tornerà mai più. Le visite di controllo però riaprono spesso le ferite, riproponendo le problematiche esistenziali esposte in precedenza. È chiaro che, superato il momento acuto, caratterizzato da risposte emozionali tendenzialmente comuni a tutti gli esseri umani, le modalità con cui si arriva alla elaborazione, accettazione e riorientamento nel proprio percorso di vita della malattia possono essere diverse da persona a persona e dipendono da fattori psicologici, spirituali, sociali e medici.
Le modalità attraverso le quali la malattia si evolve assumono evidentemente un significato specifico rispetto alla risposta psicologica individuale. È ovvio e noto nella pratica clinica che alla recidiva, all’aggravamento dei sintomi e alla prognosi sfavorevole corrisponde un impatto emotivo, psicologico e interpersonale peggiore rispetto alle situazioni la cui guarigione rappresenta l’auspicato esito della malattia. Per fortuna oggi sono sempre più frequenti le situazioni in cui il paziente, grazie all’efficacia delle terapie, guarisce, trovandosi anche a molti anni di distanza “libero” clinicamente dalla malattia. È la condizione di quei pazienti indicati come “long- survivors”. Può risultare scontato che il guarire assuma il significato di ritorno alla norma, di ripresa completa del proprio percorso esistenziale in tutte le dimensioni che lo hanno caratterizzato. In realtà le dimensioni dell’evento sono state tali per cui elementi che mantengono vivo o risvegliano il ricordo sono sempre presenti. La letteratura e la pratica clinica dimostrano infatti che assai diverse sono le conseguenze psicologiche per le persone che hanno attraversato l’esperienza del cancro e diverse quindi le situazioni riscontrabili. In alcuni casi può prevalere una modalità di evitamento di quanto è accaduto. In altri casi, l’evento della malattia e delle conseguenze che questa ha avuto determinano profondi cambiamenti interni che esitano in una profonda percezione di crescita personale che permette di affrontare l’esistenza sotto una luce diversa. In altri casi ancora la persona può mantenere un atteggiamento di preoccupazione continua che non si risolve: i sentimenti di incertezza, le preoccupazioni per la salute, il senso di perdita per come si era e per come non è più, il senso della mancanza di controllo, le difficoltà di adattamento lavorativo, i disturbi della sfera relazionale e della sessualità possono permanere.
Articolo tratto da: Biondi, Grassi, Costantini: Manuale pratico di psico-oncologia. - Il Pensiero Scientifico Editore.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Il "lutto" in psicologia ha la valenza generale di "perdita" e il processo psicoemotivo che innesca è sostanzialmente lo stesso a prescindere dal tipo di perdita subìta, purché riguardi un aspetto rilevante della vita. Si può, quindi, sperimentare un "lutto" anche dopo un licenziamento, un divorzio o la morte di un animale domestico che teneva compagnia da anni. Tuttavia, è evidente che, nell'accezione comune, il lutto per eccellenza è quello relativo alla perdita di una persona cara, esperienza a cui si evita, fin dove possibile, di pensare, ma con la quale quasi tutti, in una o più occasioni della vita, sono purtroppo costretti a confrontarsi.
Un lutto è sempre doloroso, non soltanto per l'inevitabile dispiacere di non poter più avere al fianco un affetto importante, ma anche perché impone a chi resta di ridefinire la propria esistenza e trovare un nuovo equilibrio in un sistema di riferimento affettivo e "pratico" sensibilmente modificato. Dopo essere venuti a conoscenza della perdita, è del tutto normale provare disperazione, rabbia, rifiuto della situazione, seguiti da sofferenza psicoemotiva e profonda mancanza della persona cara. Questi stati d'animo, di norma, perdurano per alcuni mesi, ma non di rado possono persistere anche per 1-2 anni.
Nel lutto "fisiologico", le emozioni negative, il disagio e il senso di colpa e smarrimento tendono a essere elaborati, più o meno consapevolmente, e ad attenuarsi con il passare del tempo, permettendo a poco a poco di recuperare un buon tono dell'umore e di ricominciare a vedere la propria vita in una prospettiva positiva. Per alcune persone questo processo di elaborazione e adattamento può essere più lento e difficile che per altre, lasciando in uno stato di significativa prostrazione molto a lungo ed esponendo al rischio di complicanze, prima tra tutte l'instaurarsi di un episodio depressivo, soprattutto in soggetti predisposti.
Per evitare di soffrire più del dovuto dopo una perdita importante è essenziale prendersi cura di se stessi, come si farebbe durante la convalescenza di una malattia, "proteggersi" da sensi di colpa, non sentirsi obbligati ad assumere determinati atteggiamenti o a provare emozioni formalizzate perché ciascuno soffre a modo proprio, con i propri tempi, le proprie difficoltà e le proprie risorse. Alcune "strategie" psicologiche e comportamentali possono aiutare a reagire positivamente a una situazione oggettivamente critica.
Le prime descrizioni della sintomatologia post lutto vennero proposte da Lindermann nel 1944 dopo un incendio al Night Club Coconut Grove di Boston. Esse comprendevano:
- Disturbi somatici di vario tipo
- Preoccupazioni riguardanti l’immagine del defunto
- Sensi di colpa nei confronti della persona scomparsa o delle circostanze della morte
- Reazioni ostili
- Perdita della capacità funzionale preesistente
- Tendenza ad assumere tratti comportamentali tipici del defunto
Questa sintomatologia gli permise di definire 3 principali stadi del lutto:
- Shock e incredulità
- Cordoglio acuto
- Risoluzione del processo di Cordoglio
Successivamente Bowlby (1982), che per molto tempo si concentrò sullo studio della costruzione e della rottura dei legami affettivi identificò 4 fasi del lutto:
- Una prima fase di disperazione acuta, caratterizzata da stordimento e protesta. Solitamente questa fase si caratterizza per il rifiuto della perdita.
- Una fase d’intenso desiderio e di ricerca della persona deceduta (alcuni mesi o anni).
- Una fase di disorganizzazione e di disperazione.
- Una fase di riorganizzazione, durante la quale gli aspetti acuti del dolore cominciano a ridursi e la persona afflitta comincia ad avvertire un ritorno alla vita.
Facendo riferimento alla teoria a cinque fasi di Kübler Ross (1990; 2002) – possiamo definire l’elaborazione del lutto come un processo che si sviluppa attraverso questi momenti:
- Fase della negazione o del rifiuto: costituita da una negazione psicotica dell’esame di realtà;
- Fase della rabbia: costituita da ritiro sociale, sensazione di solitudine e necessità di direzionare il dolore e la sofferenza esternamente (forza superiore, dottori, società…) o internamente (non essere stati presenti, non aver fatto di tutto…);
- Fase della contrattazione o del patteggiamento: costituita dalla rivalutazione delle proprie risorse e da un riacquisto dell’esame di realtà;
- Fase della depressione: costituita dalla consapevolezza che non si è gli unici ad avere quel dolore e che la morte è inevitabile;
- Fase dell’accettazione del lutto: costituita dalla totale elaborazione della perdita e dall’accettazione della differente condizione di vita.
Le sopracitate sono appunto fasi e non stadi, poiché non si assiste rigorosamente a una sequenzialità, ma esse possono presentarsi con differenti tempistiche, alternanze, intensità.
Qualora ci si renda conto di trovarsi in uno stato di sofferenza psicoemotiva eccessiva, che non dà segni di miglioramento dopo 2-3 mesi o che tende addirittura a peggiorare, è consigliabile rivolgersi a uno psicologo per avere un supporto specialistico e affrontare meglio il problema. Molto probabilmente, si sta sperimentando il cosiddetto "lutto patologico" o "disturbo da lutto complicato persistente", una vera e propria malattia psichiatrica (codificata anche nel Manuale diagnostico statistico delle malattie psichiatriche - DSM 5, nel capitolo dedicato ai disturbi dell'adattamento) che, per essere superata in tempi ragionevoli e senza rischi secondari, richiede un intervento di sostegno psicologico mirato o un breve ciclo di psicoterapia, eventualmente affiancati da una terapia farmacologica nei casi più gravi.
Chiunque può sperimentare un disturbo da lutto complicato persistente dopo la perdita di una persona cara, soprattutto se la perdita è avvenuta in modo improvviso e imprevedibile e se ha interessato una persona giovane cui si era molto legati (in particolare, un figlio). Tuttavia, la probabilità di veder perdurare la sofferenza e lo stato di prostrazione legati al lutto sono maggiori nelle persone che già soffrono di un disturbo psichiatrico o che sono predisposte a soffrirne, poiché qualunque trauma significativo agisce da fattore scatenante/precipitante. Tra i principali elementi che aumentano il rischio di sperimentare un lutto patologico vanno ricordati:
- Morte improvvisa o violenta (incidente stradale o sul lavoro, aggressione, suicidio ecc.);
- Morte di un figlio;
- Perdita di una persona molto vicina o da cui si era parzialmente dipendenti;
- Assenza di relazioni affettive solide o di una rete di supporto sociale;
- Storia di depressione o di altri disturbi psichiatrici;
- Esperienze traumatiche, abbandono o abusi nell'infanzia;
- Scarsa resilienza (capacità di reagire positivamente alle situazioni difficili/stressanti) e/o adattabilità ai cambiamenti;
- Presenza di stress significativi di varia natura (difficoltà economiche, relazioni familiari difficili, malattie ecc.).
Nei primi mesi dopo la perdita di una persona cara, le sensazioni che si provano nel caso di un lutto "fisiologico" sono del tutto sovrapponibili a quelle del lutto complicato persistente. A differenziare le due forme è essenzialmente l'andamento della severità dei sintomi, che migliorano nel primo caso e perdurano/peggiorano nel secondo. Gli aspetti cui si deve prestare attenzione, se persistenti, sono in particolare:
- Dolore profondo e disperazione associati al pensiero della persona cara venuta meno;
- Pensiero costante della persona deceduta e perdita di interesse in gran parte degli altri aspetti della vita;
- Ricordo continuo dei momenti trascorsi con la persona cara o, al contrario, tentativo di evitare ogni oggetto, frase, situazione che possa ricordarla;
- Difficoltà ad accettare la morte come fatto naturale;
- Apatia e distacco da cose e persone;
- Profonda amarezza e rabbia legate alla perdita;
- Perdita di senso, sensazione che la vita sia priva di scopo;
- Agitazione, irritabilità;
- Perdita di interesse e fiducia negli altri;
- Incapacità di trarre piacere dalle situazioni e di ripensare ai momenti vissuti con la persona cara in una luce positiva.
Un disturbo da lutto complicato persistente non riconosciuto e non trattato in modo adeguato può portare allo sviluppo di una serie di problematiche mediche, psicologiche e sociali collaterali anche molto serie, determinando un generale significativo deterioramento del benessere personale e della qualità di vita. Le principali complicanze comprendono:
- Disturbi depressivi;
- Disturbi d'ansia
- Pensieri suicidari e atti anticonservativi;
- Maggior propensione allo sviluppo di malattie organiche (in particolare, di natura cardiovascolare, infiammatoria/immunitaria, gastroenterica, tumorale ecc.) e maggior tendenza a soffrire di sindromi dolorose;
- Disturbi del sonno;
- Difficoltà a svolgere le attività quotidiane abituali, a mantenere relazioni interpersonali e a essere efficienti sul lavoro;
- Disturbo da stress post-traumatico;
- Disturbo da abuso di sostanze (droghe o farmaci psicoattivi) o alcolici;
- Abuso di nicotina.
Se dopo 2-3 mesi dalla perdita di una persona cara ci si trova in uno stato di profonda sofferenza che non accenna a migliorare è importante parlarne con uno psicologo per ottenere un supporto specialistico mirato. In particolare, lo psicologo va contattato se sono presenti:
- Difficoltà nel riprendere le attività quotidiane abituali;
- Ritiro sociale e tendenza a evitare l'interazione con familiari e amici;
- Notevole tristezza durante gran parte della giornata o vera e propria depressione;
- Profondi sensi di colpa o istinti autolesionisti (fino all'ideazione suicidaria);
- Convinzione di non aver fatto abbastanza per evitare la morte della persona cara;
- Perdita di senso, sensazione che la vita sia priva di scopo;
- Idea che la vita non sia degna di essere vissuta senza la persona venuta meno;
- Desiderio di essere morti insieme alla persona cara.
Oltre che dal diretto interessato da lutto patologico, la persistenza di questi sintomi devono essere tenuti nella massima considerazione da parenti e amici, che, in caso di riscontro positivo, devono invitare con sensibilità e delicatezza a ricercare un aiuto competente. Ciò è particolarmente importante quando i sintomi depressivi sono significativi e associati all'idea di non riuscire a vivere senza la persona deceduta e/o a pensieri di morte/suicidio.
Posto che dopo un lutto un certo grado di sofferenza è per tutti inevitabile, esistono alcuni atteggiamenti psicologici che possono contribuire a vivere l'esperienza con minori difficoltà. Un concetto apparentemente banale, ma cruciale per supportare il recupero è che la vita continua e chi resta ha non soltanto il diritto, ma anche il dovere, di ricominciare a vivere il più serenamente possibile al più presto, senza sentirsi in colpa per questo né per ciò che non si è stati in grado di dire o fare in passato per chi è venuto meno.
Un errore che capita a molti, soprattutto se la morte del familiare è avvenuta in un clima poco sereno, dopo un periodo di tensioni non risolte, o se si ritiene per qualche ragione di "non aver fatto abbastanza" quando ce n'era ancora la possibilità, è quello di sentirsi "in obbligo" di stare male, rinunciando in modo più o meno consapevole a tutte le attività che potrebbero aiutare a sentirsi meglio e a ritornare alla vita di sempre. Non c'è niente di più sbagliato, perché il passato, nel bene e nel male, non cambia e imporsi una sofferenza evitabile non aiuta nessuno. Al contrario, se, dopo un primo momento di stordimento, si percepisce il desiderio di riprendere in mano la propria vita, di dedicarsi ad attività piacevoli o di interagire socialmente lo si deve accogliere, coltivare e soddisfare.
D'altro canto, se nei primi mesi il dolore è molto profondo, non ci si deve neppure sentire in obbligo di essere "stoici per forza", di mostrarsi sereni quando dentro si hanno nuvole dense. Si deve, molto semplicemente, vivere la propria sofferenza, senza drammatizzarla, ma cercando di capirla e sfruttarla come un momento di crescita, di evoluzione personale, che può anche renderci migliori. Le persone care che sono accanto possono essere una risorsa preziosa per rinnovare la motivazione ad andare avanti nonostante la perdita.
Concentrarsi sugli affetti e sulle relazioni sociali positive, creando attivamente occasioni di incontro con parenti e amici con cui fa piacere chiacchierare, pranzare, passeggiare, trascorrere del tempo è dunque assolutamente consigliabile. Così come è consigliabile evitare tutte le situazioni obbligate: se non si ha alcuna voglia di andare a una cena o a una festa o ci si sente a disagio in compagnia di determinate persone, è del tutto legittimo declinare l'invito senza preoccuparsi di che cosa potranno pensare gli altri.
Ogni attività potenzialmente in grado di suscitare interesse o procurare piacere va incentivata, compreso il lavoro. Soprattutto se è sempre stata una fonte di stimoli positivi e mette in contatto con colleghi gradevoli e sensibili, riprendere l'attività lavorativa può essere una vera e propria ancora di salvezza, perché non c'è niente di meglio che riprendere la vita di tutti i giorni e vedere che tutto prosegue lungo gli assetti consolidati per capire che le cose possono ritrovare un loro ordine e una loro ragion d'essere.
Un altro errore da evitare è ignorare, o peggio inibire, i segnali di ripresa emotiva. Ricominciare a provare piacere in quel che si fa o amore per le persone nuove che si incontrano non è ingiusto nei confronti di chi non c'è più, né è il segno di averlo amato poco o di amarlo di meno. Di questo bisogna essere profondamente consapevoli e coltivare ogni minima emozione positiva come un dono di cui sarebbe ingiusto privarsi.
Oltre a questi consigli specifici, è importante cercare di riposare a sufficienza, di nutrirsi in modo sano ed equilibrato e di praticare attività fisica, preferibilmente all'aperto perché supportare il benessere fisico rende più forti anche sul piano psichico. Lo sport è un grande alleato per scaricare la tensione e le emozioni negative e può concretamente aiutare a recuperare più in fretta un buon equilibrio psicoemotivo. Se non si è abituati a praticarlo e non si ha voglia di iniziare in un momento difficile, è sufficiente passeggiare almeno un'ora al giorno, possibilmente in un parco o in un'area verde facilmente accessibile, per sfruttare anche il potere calmante e il senso di continuità e rinnovamento insito nella natura.
Per affrontare il disturbo da lutto complicato e persistente, ma anche per prevenirlo qualora ci si renda conto che il disagio che si sta vivendo a causa della perdita di una persona cara è francamente eccessivo, è spesso sufficiente intraprendere un percorso psicoterapico mirato di alcuni mesi, affidandosi a uno psicologo esperto di terapia del lutto.
In genere, l'approccio psicoterapico al lutto prevede interventi focalizzati sull'analisi delle difficoltà soggettive incontrate dalla persona sofferente, contestualizzati nella situazione familiare e sociale specifica.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Con il termine triade oscura della personalità si intende un insieme di tre tratti comportamentali, quali: narcisismo, machiavellismo, e psicopatia.
MACHIAVELLISMO: il termine indica una personalità manipolativa, fredda e controllata, con scarso senso morale, autocentrata e tendente all’inganno.
Nella sua opera più famosa, “Il Principe”, Machiavelli descrive le qualità che un principe deve possedere: prudenza, saggezza, capacità di simulare e dissimulare, capacità di usare la forza per mantenere la stabilità e il potere, arte della guerra, virtù, avere la forza di un leone, la furbizia di una volpe e la ragione degli uomini. Il principe ideale deve saper creare e mantenere il potere per la stabilità dello stato. Non c’è da stupirsi quindi se “Il Principe”, è tuttora citato nei migliori testi sulla leadership. Al centro del pensiero machiavellico vi è la massima “Il fine che giustifica i mezzi”. Per conservare il potere e potenziare lo Stato, “Il Principe” è giustificato nel compiere qualsiasi azione, anche quelle in aperto contrasto con le leggi della morale. Secondo molti studiosi è errato pensare ad un elogio della massima “Il fine giustifica i mezzi” in quanto Machiavelli giustifica questa condotta soltanto in nome della salvezza dello Stato. Ma di fatto, questo pensiero, ingiustamente o meno, fa apparire Machiavelli come un uomo furbo e calcolatore tanto che “machiavellico” è diventato un aggettivo che indica qualcosa di subdolo e malizioso. Secondo la classificazione de La Triade Oscura, le persone machiavelliche sono incredibilmente “strategiche” nel loro modo di approcciarsi alla vita. Le conseguenze di ogni azione sono ben ponderate: “In che modo questa azione mi porterà beneficio? In che modo questa azione influirà sulla mia immagine pubblica?” Le persone machiavelliche sono, per loro natura, abili a nascondere le loro vere intenzioni dal controllo pubblico; maestri nel fare tutto ciò che occorre per raggiungere i propri scopi, riuscendo, nel contempo, a mantenere un’immagine pubblica positiva.
NARCISISMO: il costrutto di narcisismo subclinico o normale fu proposto nel tentativo di definire una versione subclinica del disturbo di personalità narcisistica indicato nel DSM e comprende alcuni indicatori utilizzati nella diagnosi originale: grandiosità, senso di diritto, dominanza e superiorità. Molte persone pensano ai narcisisti come individui che amano apertamente se stessi. Ciò non è esatto, soprattutto quando la comprensione del narcisismo passa attraverso la lente de La Triade Oscura.
L’amore di sé si basa psicologicamente sull’autostima e sull’autoefficacia. Una buona dose di sano e benefico amore per la propria persona conduce a ideali e scelte mature, al desiderio di realizzare le proprie aspirazioni e di migliorarsi, al rispetto per sé stessi e per gli altri, a una giusta cura di sé e del proprio aspetto e ciò non significa assolutamente essere narcisisti.
I Narcisisti che soddisfano i criteri de La Triade Oscura si percepiscono come speciali, persone importanti per la storia dell’umanità, si sentono superiori. Rappresentano la migliore categoria di essere umano possibile e il loro comportamento riflette il loro senso di superiorità.
Alcune delle manifestazioni esteriori comuni di un narcisista sono l’incapacità di accettare le critiche o il dissenso in alcun modo e nel contempo la necessità di essere lusingati. I narcisisti hanno un bisogno costante di lodi, approvazione e “riconoscimento” e tendono ad organizzare la propria vita in un modo che un gruppetto di “privilegiati” possa soddisfare questo bisogno (i veri amici).
PSICOPATIA: Gli aspetti centrali del costrutto includono elevata impulsività associata alla ricerca di forti emozioni, scarsa capacità empatica e bassa presenza di ansia e rimorso (pare che gli psicopatici presentino un’alterazione nel funzionamento delle strutture cerebrali deputate al processamento della paura). La componente psicopatica de La Triade Oscura è caratterizzata da mancanza di empatia, da incapacità nel provare colpa, rimorso o lealtà verso alcuno, e dalla tendenza a coinvolgersi in comportamenti rischiosi e impulsivi.
Sfatiamo subito un mito: Non tutti gli psicopatici sono persone violente o assassini. Possono diventarlo, ma si tratta di casi eccezionali; la maggior parte degli psicopatici vive nella società con un certo successo, ma causa molti danni alle persone che ha intorno.
Spesso, ma non sempre, sono coinvolti in attività criminali, perché sono privi di coscienza. È interessante notare che ci sono psicopatici in quasi ogni professione – per esempio medici, avvocati, infermieri, insegnanti – ma queste persone imparano a contenere gli istinti e non infrangono leggi. Le stime sono variabili, ma si può affermare che circa una persona su centocinquanta (1:150) è psicopatico.
Secondo il modello di Steve Peters il cervello di uno psicopatico è privo del Centro di Umanità che il resto di noi possiede, ovvero la parte della mente che è di competenza dell’Umano (la parte razionale del cervello). Il Centro di Umanità contiene aree che evocano sentimenti come il senso di colpa, il rimorso, la compassione, l’empatia e la coscienza.
Gli psicopatici tendono a essere individui freddi e calcolatori, che usano gli altri a proprio vantaggio. Dunque, uno psicopatico è responsabile delle sue azioni? Su questo punto le opinioni divergono ma, comunque la pensiamo, sembra proprio che quest’area del cervello sia assente o inattiva.
Gli aspetti che accomunano tra loro le tre dimensioni di machiavellismo, narcisismo (subclinico) e psicopatia (subclinica) sono i seguenti:
1) La psicopatia subclinica si distingue per il basso livello di nevroticismo (indicatore che misura la tendenza ad essere ansiose, pessimiste, stressate, arrabbiate, spaventate ed emotivamente instabili)
2) Machiavellismo e psicopatia mostrano entrambi un basso livello di coscienziosità e moralità
3) Il narcisismo correla positivamente con la presenza di elevate abilità cognitive
4) I narcisisti e – in maniera ridotta gli psicopatici - condividono elevati punteggi indicativi di auto-esaltazione e senso di superiorità e "grandeur".
Gli individui caratterizzati dalla triade oscura mostrano, come abbiamo visto, alcuni tratti distintivi che derivano da forme subcliniche di narcisismo e psicopatia e dalle caratteristiche del machiavellismo:
- manipolazione
- strumentalizzazione dell’altro
- tendenza all'inganno
- freddezza emotiva
- assenza di empatia e senso morale
- assenza di rimorso e paura
- ricerca di forti emozioni
- impulsività
- senso di grandiosità e specialità
- senso di diritto
- desiderio di potere e dominanza
- cura esasperata dell’aspetto fisico
- acuta intelligenza
- tendenza all'aggressività e all'ostilità
Queste persone si muovono nel mondo più o meno impunemente, e non è affatto difficile trovarne in rete tra i disturbatori (trolls), nell’ambiente di lavoro (soprattutto all’interno della classe dirigenziale), o tra le frequentazioni interpersonali.
Sono infatti i famosi "sciupafemmine" di un tempo o i "serial lovers" di oggi a mostrare chiaramente molte delle caratteristiche della triade oscura:
- freddezza emotiva e disinteresse
- atteggiamento di sfruttamento del partner
- ricerca di sensazioni forti
- tendenza a cambiare frequentemente partner
- fanno di tutto per conquistare la preda che viene poi usata e "gettata via" senza rimorsi
- ricerca di avventure sessuali ed esperienze al limite
- abuso di sostanze stupefacenti e/o alcol
- incapacità a stabilire una relazione intima
- mancanza di senso morale
- inganni e bugie
- manipolazione
Le ricerche hanno messo in evidenza l'effetto potenzialmente distruttivo che tali individui hanno sull’ambiente e sui loro partner.
Veniamo ad un aspetto davvero interessante e anche molto delicato della questione: l’effetto che questi individui portatori dei tratti oscuri di personalità hanno sul altro sesso.
Gli studi mostrano come gli individui caratterizzati dalla triade oscura di personalità presentino strategie di accoppiamento più rapide e superficiali degli altri e vincenti nel breve periodo: essi collezionano infatti numerosi partner sessuali, hanno una spiccata propensione al sesso casuale e a sostituire un partner con un altro, hanno standard meno esigenti nella scelta del partner, mostrano la tendenza a “rubare” i partner degli altri, ed hanno un approccio pragmatico, superficiale e “usa-e-getta” alle relazioni amorose.
A questi aspetti si associano inoltre altre caratteristiche che spesso rendono questi partner eccitanti e desiderabili, soprattutto da parte di partner fragili, annoiati, delusi dalla propria vita sentimentale, professionale o generale, alla ricerca di emozioni e cambiamento bisognosi di sentirsi desiderati ed importanti.
Gli individui “Dark Triad” infatti mostrano spesso grande cura per l’aspetto fisico ed il vestiario, intelligenza e fascino (sanno essere brillanti e divertenti), manipolazione (sono in grado di comprendere perfettamente cosa il partner desidera e si aspetta da loro e sanno come ottenere ciò che vogliono), impulsività ed amore per il rischio (travolgono il partner in una girandola di emozioni e lo fanno sentire speciale e desiderato), tendenza all’abuso di sostanze, scarso autocontrollo.
Restano tuttavia individui freddi, opportunisti, sfruttatori e irrispettosi verso l’altro, ed è meglio imparare a riconoscerli e a non entrare in relazione con loro se non per una fugace e divertente avventura erotica, che presto rischierebbe di trasformarsi in una esperienza dolorosa, abusante e disorientante.
Vorrei concludere con una piccola nota. Difficilmente questi individui si incontrano dentro uno studio di psicoterapia. Molto più probabile che in psicoterapia arrivino le “vittime” di tali soggetti le quali, dopo relazioni più o meno lunghe, si sentono come “vampirizzate” emotivamente, svuotate, stanche, con poca fiducia in se stessi e verso gli altri.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Secondo Foulkes, padre della gruppoanalisi, “il gruppo è la matrice della vita mentale dell’individuo”. Egli propone l’immagine del gruppo come rete, all’interno della quale gli individui corrispondono a punti nodali; la rete del gruppo è il sistema totale di persone che vanno raggruppate insieme rispetto alla loro relazione e gli individui sono i punti nodali della rete.
Quando un gruppo di persone stabilisce rapporti intimi, si intreccia una rete intima di comunicazioni che gradualmente si sviluppa in una matrice quasi organica, all’interno della quale hanno luogo tutti i processi. La qualità particolare di tali processi è tale per cui essi passano attraverso l’individuo. È questo insieme di relazioni transpersonali che costituisce la “mente”.
La “mente” quindi consiste di processi di interazione tra un certo numero di persone strettamente collegate, chiamato comunemente gruppo. Viene così superata la contrapposizione tra realtà psicologica “interna” e realtà “esterna”: il sociale non è esterno, ma pure profondamente interno, e penetra l’essere più interno della personalità individuale.
Viene anche superata la contrapposizione individuo – gruppo: il corpo è sicuramente un’entità individuale coerente, ma esiste anche una matrice mentale sovrapersonale. Tale matrice, a partire dalle proprietà biologiche della specie, definisce il rapporto di ciascuno col mondo, organizza le “disposizioni a..” e le articola secondo il modo codificato dai valori, dalle relazioni, dalle modalità pratiche di organizzazione dell’esperienza.
L’individuo è inconsapevole di tale fondazione transpersonale: egli è normalmente convinto che il suo modo di sentire e di pensare sia quello naturale e giusto, che il suo linguaggio sia quello che si parla “realmente”.
La famiglia originaria è la rete primaria in cui si forma in modo decisivo la personalità del futuro individuo. Questa rete, oltre un asse orizzontale, comunicativo, basato sul qui e ora, ha un asse verticale che punta al passato, ai genitori, alla fanciullezza dei genitori, al rapporto dei genitori con i propri genitori, e tutto questo entra nella parte più interna del fanciullo in formazione.
La famiglia è a sua volta inscritta in una rete bio-culturale collettiva, di cui interpreta e media norma, valori, modalità relazionali.
Il transpersonale quindi si configura come la condivisione fondamentale dell’esperienza umana (Lo Verso). È l’impersonale collettivo che attraversa la nostra identità più intima senza che il nostro potere cognitivo possa minimamente concettualizzarle (Menarini). È la rete della relazioni inconsce nella quale è sedimentato il patrimonio biologico e culturale della specie umana ed attraverso la quale si fonda la vita psichica dell’uomo (Giannone).
La relazione (individuo – famiglia – collettivo), fonda radicalmente l’esperienza psichica.
La gruppoanalisi (in particolare la scuola palermitana) ha cercato di fare un ulteriore passo in avanti, rintracciando le articolazioni dei livelli collettivi cui le configurazioni personali dei singoli possono essere riferiti. Si sono individuati alcuni livelli rispetto ai quali la dimensione individuale e le dimensioni collettive possono essere messe in connessione, aprendo ad una maggiore reciproca comprensione.
Questi vari livelli del transpersonale si possono suddividere in: un primo livello che ha radici in un passato ancestrale ed è il livello biologico – genetico: noi siamo portatori di un apparato costituito dal nostro DNA, dai nostri geni, ed è comune alla specie uomo, ed è il transpersonale ad un livello biologico - genetico.
A questo livello se ne aggiunge un altro più specifico ed è quello etnico - antropologico che è funzione del luogo di nascita che organizza le aree antropologiche etniche di possibili modalità di vita, di relazioni familiari profondamente diversi. Il transpersonale di tipo antropologico si disarticola in vari livelli di tipo più specifico, infatti esistono aree del transpersonale etnico - antropologico che sono specifiche della cultura, e sono quelle che hanno a che vedere con il dove sono nato, in quale famiglia.
Il livello del transpersonale transgenerazionale riguarda la mente di un bambino allo stato nascente immerso nel codice familiare che attraversa le generazioni passate, i miti, le metaconoscenze, le categorizzazioni e le precognizioni nelle quali la storia familiare si perpetua.
Ad un altro livello c’è il transistituzionale, ossia il tipo di istituzioni specifica del luogo dove si vive, questo fa riferimento ai ruoli, alle gerarchie, alle appartenenze ed alle regole implicite ed esplicite di tipo socioculturale.
Tutti questi livelli, dal più profondo al meno profondo, sono attraversati da un livello detto socio-comunicativo, questo riguarda le modalità di trasmissione della cultura e dei livelli di socialità attraverso la verbalizzazione e la narrazione.
Infine il transpersonale politico ambientale che attraversa i precedenti livelli ed ha a che fare con gli stati nascenti della comunità; è il luogo dove l’individuale diventa parte del collettivo e il collettivo costituisce l’individuale.
Ora, benché nessuno di questi aspetti è isolabile dagli altri, l’aspetto su cui si lavora di più in una psicoterapia analitica ad orientamento gruppoanalitico è quello transgenerazionale. Questo perché la gruppoanalisi soggettuale guarda alla famiglia come una trama di significazione che, nel tempo e attraverso le generazioni, crea i modelli mentali attraverso i quali l’individuo entra in relazione con la realtà. La famiglia rappresenta, quindi, un vero e proprio “universo identificatorio” all’interno del quale, come dicevamo, ciascun individuo sviluppa la sua identità come complesso di relazioni interiorizzate.
Proprio sullo studio della famiglia intesa come campo mentale attraversato da scambi inter e transgenerazionali, molti autori hanno speso molto del loro impegno scientifico definendo “insature” le matrici familiari che consentono il rimodellamento simbolico dei loro temi e complessi culturali e “sature” le matrici familiari ove si riscontra un’indisponibilità a tale rimodellamento. Premesso che rimodellare i sistemi simbolici è compito peculiare della specie sapiens, e premesso che tale rimodellamento non è effettuabile da un individuo solo poiché è un processo che richiede reciprocità e partecipazione della comunità, questi autori si sono chiesti che succede agli individui cresciuti all’interno di campi mentali familiari non disponibili al rimodellamento delle loro trame simboliche. E, attraverso una lunga esperienza clinica hanno avuto modo di sostenere che, a questi individui può succedere di diventare esponenti della sofferenza appartenente al loro gruppo familiare (costretto entro alcune significazioni, o mai in contatto con le vere scaturigini degli atteggiamenti e delle storie che si tramandano).
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
La Clinica Gruppoanalitica
Un contributo importante che la clinica gruppo analitica ha dato alla comprensione dello sviluppo mentale normale e patologico deriva dall’individuazione di una dinamica transpsichica transgenerazionale alla base di tale sviluppo.
Fu lo stesso Foulkes (il fondatore della Gruppoanalisi) a cogliere immediatamente tale interconnessione durante le sue prime terapie di gruppo: “considero il paziente che mi sta di fronte come l’anello di una lunga catena, un punto nodale in una rete di interazione, la quale è la vera sede dei processi che portano tanto alla malattia quanto alla guarigione. Sono sempre più convinto che il paziente che noi vediamo è in se stesso solo un sintomo di un disturbo che investe un’intera rete di situazioni e di persone, che costituisce l’autentica sede di intervento di una terapia radicale ed efficace”.
La teoria dello sviluppo mentale secondo la gruppoanalisi privilegia l’assunto secondo il quale la personalità si costruisce strutturandosi in relazione al campo mentale familiare inteso come una trama di pensiero collettivo chiamata “matrice familiare”. Tale processo strutturante si realizza mediante l’assimilazione da parte del bambino dei modelli di pensiero della famiglia cui appartiene e dei suoi “temi culturali”, definibili come peculiari costrutti emotivo-cognitivi che condensano tanto le vicissitudini esistenziali della famiglia e delle generazioni precedenti, quanto le modalità psicologiche costruite appunto per dare senso a tali vicissitudini. Ogni famiglia è quindi caratterizzata da una particolare cultura che affonda le radici nella sua storia e in quella delle generazioni precedenti. L’interazione tra questa cultura familiare e il mondo interno del bambino determina lo sviluppo di quella trama relazionale definita “matrice personale” proprio per definire il concetto di fondazione culturale della mente: in questo senso la nostra mente è sostanzialmente gruppale.
Per realizzare fisiologicamente tale strutturazione antropologica della mente cui è finalizzata, la matrice familiare deve potersi costituire come spazio transazionale (o matrice familiare insatura) dal quale sia possibile per il bambino dare significato alle generazioni e culture precedenti e parallelamente dare un senso all’ignoto del nuovo progetto evolutivo. Il bambino diventa persona quando può trasformare simbolicamente (inconsciamente) in nuovi significati la cultura familiare e trans personale, cioè quando può pensare la discontinuità evolutiva attuale rispetto alla cultura degli antenati storicamente data. All’impossibilità di tale rappresentazione mentale è correlata l’insorgenza di linee di frattura (trans generazionali) potenzialmente psicopatogene, le quali segnalano realtà “non pensabili” che possono intrappolare il paziente nella rete impedendogli la sua completa individuazione (lo sviluppo di una sana matrice personale).
Su questa base, il sintomo psichiatrico (o il malessere psicologico) si configura come conseguenza della non avvenuta trasformazione dei temi culturali in eventi simbolici all’interno del pensiero. In quest’ottica la psicopatologia è visualizzabile come la conseguenza di un fallimento della matrice familiare nella sua funzione di spazio transazionale, come mancata trasformazione significativa della storia delle generazioni precedenti: in tal caso parliamo di “matrice familiare satura”.
Ne deriva che la funzione essenziale della matrice familiare è quella di garantire al bambino la possibilità di fondare un suo apparato mentale autonomo (discontinuo) attraverso la trasformazione significativa della rete transpersonale, cioè della cultura degli antenati. Soltanto la famiglia in quanto pensiero gruppale può assolvere a questo compito impossibile per un pensiero individuale.
La capacità della famiglia di costruire relazioni significative tra la propria storia, la storia degli antenati e il nuovo progetto storico del bambino, permette al bambino stesso di organizzarsi come sintesi dialettica all’interno di questi tre campi: di fondarsi come persona. Se invece la famiglia non riesce a dare senso al nesso esistente fra la sua storia e quella delle generazioni precedenti, anche il nuovo progetto storico del bambino sarà minato da “aree senza senso” potenzialmente psicopatogene. In questo caso, infatti, verrà alterato il processo di costruzione della persona intesa come nodo della rete transgenerazionale: l’esito di tale alterazione potrà consistere appunto nell’insorgenza di un’evidente sindrome clinica psicopatologica o nella stabilizzazione di un disturbo di personalità.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
I diversi tipi di Psicoterapia
Ad oggi vi sono diversi tipi di psicoterapia. Bisogna innanzi tutto operare una distinzione, che in genere crea molta confusione, tra la modalità di psicoterapia, che riguarda le persone a cui la terapia è rivolta (per cui avremo: la psicoterapia individuale, la psicoterapia di coppia, la psicoterapia familiare, la psicoterapia di gruppo) e il tipo di psicoterapia, che riguarda l’approccio teorico e le tecniche pratiche della terapia.
In molte occasioni, quando una persona prende coscienza di dover andare dallo psicologo, continua a mantenere certe idee erronee su cosa sia la psicoterapia. Spesso ha in mente la classica scena di un paziente sdraiato sul divanetto con il terapeuta dietro di lui che prende appunti. La classica immagine della psicoanalisi continua a pesare moltissimo nel subconscio collettivo.
Il tipo di psicoterapia si differenzia in base alla teoria e alla pratica che lo psicoterapeuta utilizza nel suo lavoro. Nel corso di questo e dello scorso secolo si sono sviluppati moltissimi approcci teorici e pratici diversi, moltissimi punti di vista sull’uomo e sulla sua salute psicologica. Di conseguenza i tipi di psicoterapia sono oggi tantissimi.
Possiamo comunque affermare che, seppur da punti di vista differenti, l’obiettivo generale è lo stesso per tutte: migliorare lo stato di benessere e aiutare le persone a realizzare il proprio potenziale.
Presenterò adesso vari tipi di psicoterapia. L’elenco non vuole essere esaustivo, né vuole essere una classifica con il fine di individuare quale tra i vari orientamenti sia il migliore: tutti i tipi di psicoterapia possono essere efficaci se il professionista è competente e se si crea una buona alleanza terapeutica. Alla gruppoanalisi, il mio orientamento, dedicherò in seguito un articolo a parte. Iniziamo!
- Psicoanalisi: Fondata da Sigmund Freud, è una teoria psicologica che ha introdotto i concetti di inconscio, transfert, conflitto psichico e pulsioni La Psicoanalisi è stata la prima forma di psicoterapia concettualizzata e formalizzata nella storia moderna. Oggi si è frazionata in varie correnti, tuttavia possono essere individuati alcuni elementi comuni della pratica clinica, quali: il lavoro sui sogni e sulle fantasie, l’espressione dei pensieri liberamente associati dalla persona, l’attenzione alla relazione terapeuta-paziente.
- Psicologia Analitica: o Psicologia del profondo. Originata dalle idee del famosissimo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, è sia una teoria psicologica sia un metodo di trattamento. Mira a promuovere la condizione di “integrità” dell'essere umano, esplorando gli elementi inconsci propri della singola persona o appartenenti all'intera specie umana (chiamati “archetipi”). La persona è stimolata a dare senso al proprio inconscio, a individuare le proprie modalità disfunzionali inconsapevoli (chiamate “complessi”), a riappropriarsi delle energie mentali che prima disperdeva inconsapevolmente al fine di percorrere il viaggio verso la realizzazione del proprio potenziale (viaggio chiamato “individuazione”).
- Psicodramma: Psicoterapia di gruppo che, attraverso l’uso del gruppo, di tecniche di role-playing o di estrazione teatrale, invita le persone a rappresentare diversi scenari (eventi della propria vita, fantasie, sogni o emozioni) stimolandola a divenire consapevole delle proprie emozioni e dei propri conflitti e a trovare nuove soluzioni.
- Psicoterapia Psicodinamica: La persona è stimolata a considerare le proprie emozioni, credenze, esperienze infantili e il tipo di rapporto che instaura col terapeuta al fine di individuare (e cambiare) le modalità relazionali attuali fonte di disagio, mediante l’utilizzo di concetti teorici e metodologici psicoanalitici.
- Psicoterapia Adleriana: Ideata da Alfred Adler conduce il paziente all’esplorazione di sentimenti di inadeguatezza e inferiorità originati in base alla propria storia familiare infantile o conseguenza di alcuni difetti fisici della persona. Mira allo sviluppo della fiducia e dell’autostima, l’individuazione del proprio significato individuale della vita e l’accrescimento delle capacità di avere relazioni intime e positive con gli altri.
- Analisi Bioenergetica: Fondandosi sul principio secondo cui l’energia del corpo influenza il benessere emotivo e mentale della persona, cura i disturbi psicofisici lavorando sia al livello fisico, con esercizi corporei, sia al livello psichico, utilizzando concetti e tecniche mutuati dalla Psicoanalisi (conflitto edipico, lavoro sui sogni, analisi del transfert).
- Terapia Centrata sul Cliente: Ideata da Carl Rogers, considera l’individuo come provvisto per natura delle capacità necessarie per affrontare le proprie difficoltà esistenziali. La relazione paziente-terapeuta è fondamentale e quest’ultimo stimola la persona in difficoltà a rivitalizzare le proprie capacità di crescita e di cambiamento, lavorando per creare un clima di accoglienza e ascoltandola autenticamente e empaticamente.
- Terapia Sistemico Familiare: Anche se il disagio psicologico può riguardare solo alcuni membri di una famiglia o, come molto spesso accade, è una sola persona della famiglia a soffrire di una difficoltà psicologica, alle sedute partecipano tutti di membri della famiglia. La persona sofferente, che porta con se un disagio psicologico, è vista come “l’espressione” del contesto familiare squilibrato: il terapeuta, durante le sedute, non si focalizza solo su di essa ma su tutti i membri della famiglia, stimolandone il cambiamento dell’intero nucleo familiare.
- Analisi Transazionale: Ideata dallo psichiatra americano Eric Berne, è sia una teoria psicologica sia un approccio psicoterapeutico. La pratica clinica, che integra differenti approcci (Psicoanalisi, Psicoterapia Cognitivo - comportamentale e Gestalt), mira a migliorare le relazioni della persona sia con gli altri sia con se stessa.
- Terapia della Gestalt: Il terapeuta aiuta la persona, mediante tecniche e esercizi, a focalizzarsi sul momento presente, sulle sue convinzioni, emozioni e sensazioni fisiche che sta sperimentando nel qui-e-ora: il passato e il futuro sono presi in considerazione allorché influenzano il momento presente. L’obiettivo della terapia della Gestalt è lavorare sulla nostra autocoscienza in modo che possiamo risolvere i nostri problemi con maggiore sicurezza. L’obiettivo dei procedimenti previsti da tale approccio terapeutico è indurci a mettere da parte le angosce della vita, raggiungere la libertà personale e acquisire la determinazione sufficiente per raggiungere il nostro massimo potenziale.
- Psicoterapia Sensomotoria: Attraverso l’uso del corpo e la consapevolezza di aspetti cognitivi ed emotivi conduce la persona a scoprire come le esperienze fisiche del suo passato siano ancora attive nel suo presente.
- Psicoterapia Cognitivo – comportamentale: La persona viene aiutata a cogliere come i propri pensieri e convinzioni determinino le proprie difficoltà emotive e comportamentali, attraverso tecniche differenti, che vanno dal rilassamento muscolare, alla messa in discussione delle convinzioni negative o irrealistiche, al mantenere un diario quotidiano, allo stimolare nuovi comportamenti.
- Schema Therapy: Si focalizza sugli “schemi” che la persona ha sviluppato nell’infanzia, modelli di pensiero-sensazioni-emozioni-comportamenti costruiti “ieri” che provocano disagio “oggi”. Per modificare l’effetto distruttivo di tali schemi vengono applicate teorie e tecniche della Psicoterapia Cognitivo - comportamentale, della Psicoanalisi e della Terapia della Gestalt.
- Terapia Cognitiva basata sulla Mindfulness: Approccio terapeutico di gruppo che coniuga le strategie della Psicoterapia Cognitivo - comportamentale con la Mindfulness (tecnica di meditazione di derivazione Buddista)
- Terapia dell’Accettazione e dell’Impegno: Le persone sono incoraggiate a prendere contatto con le proprie emozioni negative, ad accettarle e a smettere di evitare le situazioni che possono stimolare emozioni negative mediante strategie di accettazione e meditazione (Mindfulness) e tecniche di cambiamento del comportamento.
- Musicoterapia: è una terapia creativa molto versatile, intensa e curativa al contempo. I cambiamenti sono quasi immediati e lo si può vedere con molta frequenza in pazienti con disturbi dello spettro autistico e demenze. Il paziente risponde subito e sperimenta tutto un torrente di emozioni e sensazioni.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Uno psicologo, uno psicoterapeuta ed uno psichiatra entrano in un bar…
Il titolo ricorda molto quelle vecchie barzellette in cui tre persone molto diverse da loro per razza, o per nazionalità, o per altre caratteristiche peculiari della personalità, entrano in un bar e ognuna di loro risponde in modo molto diverso ad una situazione. Solitamente queste barzellette puntavano ad esaltare delle differenze che si rifacevano a qualche luogo comune.
Ho usato questo titolo perche solitamente le tre figure professionali del titolo sono anch’esse permeate e circondate da luoghi comuni, e spesso le si confonde tra loro con il risultato che chi ha bisogno di aiuto non sa bene a chi rivolgersi.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza, iniziando dalla differenza tra i percorsi formativi e la natura della loro attività professionale.
Diventare Psicologo: Lo Psicologo è laureato in Psicologia, ha svolto un tirocinio professionale di un anno, ha superato l’Esame di Stato per l'abilitazione professionale e si è iscritto all’Albo professionale (Sezione A) dell’Ordine degli Psicologi. Senza l'iscrizione all'Albo (Sezione A) non si ha diritto ad utilizzare il titolo di “Psicologo”, ma soltanto quello di “Dottore in Psicologia”. Nel 2001 è nata la figura del “Dottore in Tecniche Psicologiche” che, a differenza dello Psicologo che ha una laurea quinquennale, ha conseguito una laurea di soli tre anni, ha effettuato un tirocinio di 6 mesi, ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo – Sezione B. Poiché il panorama formativo si sta facendo sempre più complesso, queste precisazioni sono doverose al fine di definire la figura dello Psicologo e distinguerla da figure professionali limitrofe. In ogni caso è possibile controllare l’iscrizione all’Albo di uno Psicologo consultando la sezione Albo Nazionale del sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
Diventare Psicoterapeuta: Il percorso formativo per diventare Psicoterapeuta è piuttosto lungo. Innanzi tutto occorre essere o Psicologo o Medico chirurgo, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale. In secondo luogo occorre frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia della durata di almeno quattro anni riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Diventare Psichiatra: Lo Psichiatra ha una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione post-lauream in Psichiatria. Ovviamente anche lui fa riferimento al suo ordine professionale al quale si iscrive dopo la laurea e dopo aver sostenuto l’esame di stato.
Anche nella pratica clinica l’approccio di queste tre figure professionali può essere molto diverso.
Lo Psicologo svolge la propria attività professionale in settori molto diversi: nel settore clinico, occupandosi di disagio mentale, nel settore scolastico, promuovendo il benessere psicologico all’interno degli istituti scolastici, nel settore organizzativo, operando per migliorare il funzionamento di aziende e industrie, e nel settore accademico, svolgendo ricerca e insegnamento.
Lo Psicologo clinico utilizza gli strumenti di valutazione, di prevenzione e di intervento sul disagio psichico appresi durante il corso di laurea. Lo Psicologo esegue una diagnosi utilizzando il colloquio e gli strumenti diagnostici, come ad esempio i questionari e i test di personalità. Fa azione di prevenzione e di intervento sul disagio psichico dei propri clienti promuovendo la consapevolezza dei propri modi di pensare, di sentire e di agire, rinforzando le capacità dei propri clienti di vivere in autonomia e benessere.
Le differenze nello svolgimento dell’attività professionale dello Psicologo clinico e dello Psicoterapeuta si basano sul fatto che lo Psicoterapeuta è l’unico abilitato a fare psicoterapia, ossia il trattamento finalizzato alla cura dei disturbi psicopatologici basato sull’interazione tra lo Psicoterapeuta e un paziente, una coppia, una famiglio o un gruppo. La definizione sembra netta e inequivocabile, ma in realtà vi è tutto un contenzioso in corso circa i limiti delle due professioni. Lo Psicologo è infatti legalmente abilitato a utilizzare strumenti di intervento per la riabilitazione in ambito psicologico, il che sembra essere molto simile all’attività psicoterapeutica.
Si dice comunemente che il lavoro dello Psicoterapeuta vada più in profondità del lavoro di consulenza di uno Psicologo. Questo non è necessariamente vero. A mio parere molto dipende dall’esperienza del professionista. In genere però, lo Psicoterapeuta è molto più preparato dello Psicologo in tema di psicopatologia e utilizza specifiche tecniche terapeutiche di intervento che ha appreso durante il suo lungo corso di specializzazione e che non possono essere utilizzate dagli Psicologi. A volte però il confine non è di facile individuazione.
Data la grande varietà di scuole di specializzazione, gli Psicoterapeuti possono operare con metodologie di lavoro e visioni dell’uomo molto diverse tra loro. Per questo motivo è importante farsi un’idea preventiva di come lo Psicoterapeuta lavora prima di intraprendere un percorso terapeutico. È sempre bene chiedere preventivamente al professionista cui ci si rivolge quale formazione ha svolto e quali titoli può utilizzare. Se il professionista non ha nulla da nascondere, sarà felice di dare le informazioni richieste.
Lo Psichiatra si occupa di disturbi mentali a carico del sistema fisico dell’essere umano. Lo Psicologo guarda agli aspetti emotivi, cognitivi e relazionali del disturbo mentale.
Le conseguenze sul lato pratico sono notevoli: lo Psichiatra richiede e valuta esami medici, prescrive farmaci generici e psicofarmaci. Lo Psicologo non prescrive farmaci, ma utilizza come strumenti di intervento il colloquio, la somministrazione di test, il sostegno empatico e - se è anche psicoterapeuta - le tecniche di intervento psicoterapeutiche.
Lo Psichiatra, che è innanzi tutto un medico, ha un rapporto col paziente di tipo medico-paziente ossia un rapporto asimmetrico in cui il paziente è la parte dipendente in stato di necessità, mentre il medico ha il ruolo del professionista competente che sa, guida e dà prescrizioni. Lo Psicologo punta invece sul rapporto paritetico col paziente, un rapporto individuo-individuo in cui sia presente innanzi tutto la fiducia, perché senza la fiducia nessun lavoro psicologico può essere portato avanti.
Lo Psichiatra tende a curare il disagio psichico andando a riequilibrare gli scompensi chimici che vengono a crearsi nel cervello di una persona sofferente. Ad esempio è stato rilevato che, in concomitanza di alcune forme di depressione, l’attività di un neurotrasmettitore chiamato serotonina – una sorta di messaggero dell’attività psichica – è meno intensa. Lo Psichiatra interviene su questo scompenso sul piano fisico, somministrando uno specifico farmaco per la psiche – uno psicofarmaco – che incrementa l’attività della serotonina. Il paziente sta meglio ma deve continuare ad utilizzare gli psicofarmaci.
Lo psicologo è cosciente degli squilibri chimici ma preferisce correggerli con un’altra strategia: vuole riattivare le risorse, la capacità di scelta, le emozioni positive del paziente in modo che stia meglio e sia in grado di riequilibrare da sé gli squilibri chimici del proprio cervello.
Talvolta queste professioni collaborano nel perseguire la salute di un dato paziente. In questi casi il disturbo viene affrontato in modo parallelo sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista psichiatrico. Questo può avvenire quando un paziente presenta sintomi molto gravi che possono culminare nell’aggressione o nella distruzione di sé o di altre persone. In questi casi lo Psichiatra somministra una terapia farmacologica che limiti la distruttività del paziente, mentre lo Psicologo lavora per riattivare le risorse di crescita del paziente.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
Cos'è lo Psicologo e cosa può fare dal punto di vista legale
Nel 1989 è stata emanata la legge n. 56 che ha definito e regolamentato la professione dello Psicologo, fino a quel momento presente sul mercato senza uno specifico riconoscimento legale.
Definizione della professione di Psicologo
L’articolo 1 della legge è il più importante in quanto definisce concretamente la professione dello Psicologo.
Riporto integralmente l’articolo:
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
Vediamone i termini chiave:
- Strumenti conoscitivi: sono i modelli concettuali con cui lo Psicologo interpreta i fatti che incontra nella sua professione: i comportamenti, le emozioni e i pensieri delle persone. I modelli concettuali sono vari e diversi e sono influenzati dalle scuole di pensiero cui lo Psicologo aderisce, ma sono estremamente utili.
- Strumenti di intervento: a differenza dei Medici che intervengono mediante la terapia farmacologica e la chirurgia, gli Psicologi utilizzano strumenti di intervento basati sulla parola e sulla relazione, come ad esempio il colloquio, il sostegno empatico, il training autogeno, la formazione, l’ipnosi.
- Prevenzione: l’attività volta a impedire la manifestazione, o a ridurre la probabilità di insorgenza, di una situazione problematica.
- Diagnosi: lo Psicologo utilizza gli strumenti di valutazione, quali i test, i questionari e il colloquio clinico, per individuare la presenza di eventuali disturbi mentali.
- Attività di abilitazione-riabilitazione: sono le attività terapeutiche che gli Psicologi mettono in atto per curare i disturbi mentali o per aiutare le persone che stanno attraversando dei momenti di difficoltà esistenziale. Con abilitazione si intende l’acquisizione di un’abilità mai posseduta prima, come ad esempio potrebbe essere il caso di una persona che si rivolge ad uno Psicologo perché non ha mai avuto rapporti di intimità con l’altro sesso e vuole acquisire la capacità di averne.
Con riabilitazione si intende il recupero di una funzione compromessa, come potrebbe essere il caso di una persona che a seguito di un divorzio ha perso la capacità di avere rapporti di intimità con l’altro sesso.
- Sostegno: sostenere non significa promuovere il cambiamento di una persona, ma aiutarla a mantenere l’impegno richiestogli dalle sfide della vita per conservare il suo attuale livello di salute. Lo Psicologo sostiene stimolando le persone a utilizzare le proprie capacità, come ad esempio sostenendo i familiari di un malato cronico affinché si attivino e facciano fronte alla situazione problematica in modo costruttivo.
- Persona, gruppo, organismi sociali e comunità: lo Psicologo non si rivolge solo ai singoli, ma anche ai gruppi di persone – come ad esempio le coppie e le famiglie. Lavora anche con e negli organismi sociali – come le scuole, le aziende e gli ospedali – e le comunità – come le comunità psicoterapeutiche, le comunità per tossicodipendenti, le case di riposo per anziani.
Requisiti per l'esercizio dell'attività di Psicologo
L’articolo 2 stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo, che sono: essere laureato in Psicologia, aver svolto un tirocinio professionale, aver superato l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
Esercizio dell'attività psicoterapeutica
L’articolo 3 afferma che l’attività di psicoterapia può essere svolta solo dagli Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tale fine riconosciuti.
Albo professionale
Gli articoli dal 4 al 28 riguardano l’istituzione e il funzionamento dell’Albo professionale e dell’Ordine degli Psicologi – che è l’organizzazione predisposta a mantenere l’Albo professionale. L’Ordine è strutturato in Consigli, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che svolgono le attività pratiche di manutenzione dell’Albo: verificano i requisiti degli iscritti all’Albo, esaminano le nuove domande dei candidati, cancellano le iscrizioni quando occorre, infliggono le sanzioni disciplinari.
Professione sanitaria
La psicologia è una professione sanitaria, come ratificato dall’articolo 29 che recita: “Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi”.
Il resto del testo di legge – gli articoli dal 30 al 36 –riguarda argomenti di minore importanza in materia di equipollenza dei titoli di laurea esteri e di procedure per l’avviamento dell’Albo e dei Consigli.
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo
In questo articolo troverete l’intervista telefonica che “Le Iene” hanno fatto ad una ragazza che soffre di ansia e attacchi di panico. Penso che le parole provenienti da una persona che prova in prima persona tutta una serie di difficoltà valgano molto di più di mille articoli teorici proposti da uno psicoterapeuta. Auguro a tutti una buona lettura. In fondo alla pagina trovate il link al sito delle Iene in cui è stata pubblicata l’intervista che segue.
“Passavo le serate a letto, al buio, guardando il vuoto, con la paura che tornasse un nuovo attacco”. Jessica Maritato, 27 anni, racconta come combatte ansia e attacchi di panico con cui convive fin da bambina. Spazio aperto per chi vuole condividere la sua storia (anche in anonimato).
Apriamo una porta su un mare grande di segnalazioni, quelle che arrivano da chi soffre di ansia e attacchi di panico. La prima a metterci letteralmente la faccia, qui sopra, è Jessica Maritato, 27 anni. Ma lo spazio è aperto anche per chi preferisce l’anonimato, come a chi vuole fare una breve intervista video. Per raccontare e condividere la propria storia, cercare e proporre soluzioni. Partiamo intanto con Jessica, che si è sottoposta alla batteria di domande per telefono.
Qual è stato il momento peggiore?
“Tra maggio e giugno del 2015. La mia giornata tipo in quel periodo era: sveglia, attacco di panico, vomito, tremore, freddo, mio padre che mi sorreggeva e mi portava alla finestra a prendere un po’ d’aria. Mi rimettevo 10 minuti nel letto ancora tremante. Quando riuscivo a tornare con la testa alla realtà, mi lavavo, mi vestivo e mi facevo accompagnare a lavoro sempre da mio padre. Passavo la giornata in catalessi, cercavo di sorridere e fingere che andasse tutto bene. Rientrata a casa, stremata, mi lasciavo andare e abbassavo le difese. E lì tornava, vigliacco, l’attacco di panico. Passavo le serate a letto, al buio, guardando il vuoto. Non leggevo più, non uscivo più, non ascoltavo più la musica e non riuscivo nemmeno a guardare un film o la televisione. La mia testa era altrove, non riuscivo a distrarmi dall’unico pensiero fisso che avevo: la paura del ritorno di un nuovo attacco di panico”.
Erano i tuoi primi attacchi?
“Sì, almeno quelli di cui ero consapevole. Il negozio dove lavoravo stava chiudendo, ero terrorizzata all’idea di perdere il lavoro. Andando in terapia ho capito dopo che il problema non era il lavoro ma qualcosa di più profondo. Ho capito anche che avevo già avuto degli attacchi di panico in passato, perfino da piccola, ma non sapevo riconoscerli”.
Più ansia o panico per te?
“L’ansia mi tiene per mano da quando sono bambina. Ogni volta che devo affrontare una cosa nuova, una situazione diversa, qualcosa che non conosco, anche un luogo nuovo per esempio, ho l’ansia. L’ansia sale e scende, ci sono momenti in cui è molto presente e altri in cui mi rendo conto che è chiusa in un cassettino della mente. Ma so che c’è. Lei c’è sempre. Gli attacchi di panico ora ho imparato a riconoscerli, a gestirli e talvolta pure a prevenirli”.
Come si manifestano? Cosa ti succede?
“L’attacco di panico, una volta che l’hai provato, lo riconosci subito. Tachicardia, sudore alle mani, tremolio, bocca secca, mancanza di respiro, agitazione. Non riesci più a parlare e non riesci nemmeno a spiegare cosa ti sta succedendo e perché. Soprattutto, ti sembra di morire. Chi ha provato un attacco di panico sa che la sensazione che prevale su tutto: ‘Sto morendo, ora’. È la sensazione più brutta che abbia mai provato. È per questo che, quando lo provi una volta, poi sei terrorizzata che possa ripetersi”.
Come li combatti?
“Li combatto affrontandoli. Non ho mai fatto un giorno di malattia per questo, piuttosto mi tenevo tutto dentro ed esplodevo dopo. Avevo paura che se l’avessi fatto una volta, l’avrei fatto sempre. Avevo già rinunciato a uscire con il mio fidanzato o con gli amici e non potevo isolarmi totalmente dalla vita. Ora, rispetto a 3 anni fa, ho maggiore consapevolezza".
Cioè?
"So che non morirò, so che mi sentirò stanca e debilitata, ma passerà. Vado avanti a braccetto con l’ansia, a volte è talmente pesante che mi trascina lei, altre volte è piccola e leggera. Cerco di affrontarla sempre, sempre, sempre. La mia più grande preoccupazione era il giudizio degli altri, ho smesso di preoccuparmi di quello, e mi sono tolta il 50% del problema”.
Come è cambiata la tua vita?
“A cambiarmi è stata la terapia, con l’ansia credo di esserci nata quindi non riesco a fare paragoni. Non c’è un prima e un dopo l’ansia. La terapia, invece, ti cambia, in meglio. Ti aiuta a conoscerti perché c’è sempre, o quasi sempre, un perché arrivi ad avere un attacco di panico. A volte è un perché che nemmeno ti immagini, a volte sono tanti perché, altre ancora sono motivi che già conoscevi ma che nascondevi sotto il tappeto”.
Ti senti capita?
“Assolutamente no. Sicuramente le persone a me più care provano a capirmi e a starmi vicino, ma non capiscono realmente cosa e come sia convivere con l’ansia. Credo sia impossibile capire cosa vuol dire avere un attacco di panico e vivere perennemente in apnea. O sei cosi o non lo sei. È un po’ come quando si parla di depressione e le persone dicono: ma ha tutto dalla vita, sta bene, ha una bella famiglia, ha un buon lavoro, fa una bella vita… purtroppo queste cose non si controllano, non si decidono, non le cerchiamo e non le vogliamo, come una qualsiasi malattia che colpisce il fisico”.
Cosa ti dà più fastidio nell’atteggiamento degli altri?
“Chi ti dice: a me sembra che stai bene, sei allegra, scherzi sempre. Dovrei indossare una t-shirt con scritto “Soffro d’ansia”? Ultimamente va pure di moda dire: “Oddio, ho l’ansia”. Spesso confondiamo le sensazioni: l’agitazione, l’emozione, la trepidazione dell’attesa con l’ansia. È uno dei motivi per cui molti sottovalutano il problema: credono si sapere di cosa si parla, invece è proprio un’altra cosa”.
Ti senti mai “debole” o “fifona”?
“Mi sentivo molto debole, fifona, sbagliata, esagerata, una che fa del vittimismo. La terapia mi ha aiutata ad accettarmi. Io sono così. Fifona e debole? Sì, agli occhi di qualcuno sicuramente. Ora, però, mi sento forte. So solo io quanta fatica faccio ogni volta che vado dalla psicologa, so solo io come ne esco distrutta. Alla fine di ogni seduta sembra che mi sia passato sopra un tir, mi sento di aver fatto una centrifuga in una mega lavatrice o come se avessi camminato nuda in piazza Duomo. So solo io quanto è difficile affrontare le mie paura, le mie ansie, arrivare a fine giornata con fatica, ma arrivarci avendo fatto quello che mi ero prefissata”.
Meglio i farmaci, lo psicologo o lo psichiatra? Oppure fare da sé, aiutata magari da familiari/amici/compagno?
“Per me l’unica cosa che aiuta davvero è la terapia. Lo psicologo e, se necessario, terapie farmacologiche. Solo lo psichiatra può prescriverti però dei medicinali. Nel 2015 ho preso anche dei farmaci, per 6 mesi, e non mi hanno mai dato né problemi né dipendenza. Lo psicologo purtroppo è una figura sottovalutata”.
Perché?
“Andarci non può essere ancora un tabù nel 2018. È assurdo associare il fatto di andare da uno psicologo a una debolezza o a un capriccio oppure a chissà a quale grave malattia mentale. È vero: costa, ma ci luoghi in cui puoi cercare aiuto da un professionista gratuitamente. Il costo è relativo, dipende sempre dalle priorità di ognuno. Mi hanno fatto i conti tasca milioni di volte: ‘Ah, ma tu puoi’. No, io voglio, punto. Io voglio stare meglio, voglio avere il controllo delle mie emozioni e della mia vita. Questa è la mia priorità".
Hai fatto rinunce per continuare con la terapia?
"L’ultimo modello di iPhone, la cena fuori, la serata a ballare, le scarpe nuove, le unghie laccate, i capelli perfetti, le ciglia finte, la macchina belle e potente… non sono, al momento, una mia priorità. Vorrei vivere in un Paese in cui andare dallo psicologo sia normale, come dire ‘Oggi vado a fare la ceretta’! Vorrei vivere un Paese che mette a disposizione un servizio gratuito per tutti, un servizio che funzioni però! Se non andassi in terapia e risparmiassi questi soldi, ma non riuscissi a uscire di casa come starei? So che tornerei come nel 2015 quando non mettevo piede fuori casa, se non per andare a lavoro. Sul letto, senza appetito, con un nodo in gola e uno nello stomaco, con gli occhi gonfi, le mani tremanti e sudate: cosa me ne farei di quei soldi risparmiati?”
Problemi con il lavoro per i tuoi disturbi?
“Lavoro per un’azienda di abbigliamento da 6 anni: come commessa in negozio per 6 mesi e gli altri 6 nello showroom aziendale, in un ambiente molto tranquillo, quasi familiare. Non ho mai avuto problemi. Ho dei colleghi eccezionali, comprensivi, gentili e sempre pronti a sostenermi. Non mi sono mai sentita giudicata da loro, non mi hanno mai detto qualcosa che mi ha fatto sentire sciocca e fifona. Mi sono sempre stati accanto come potevano, con una parola, un abbraccio o un semplice sorriso d’amore”.
Ne hai parlato in famiglia o con il tuo compagno?
“Ne ho parlato e ne parlo tuttora, sempre. La mia famiglia e il mio compagno sanno tutto e hanno assistito a ogni mio regresso e progresso. Ne ho parlato apertamente nel 2015, o meglio, è stato mio padre a capire che c’era qualcosa che non andava e mi ha spinta ad andare dalla psicologa. Mio padre è una persona semplice che non sa nemmeno cosa significhi andare in terapia e che forse nel passato storceva il naso quando si parlava del mestiere dello psicologo. Eppure si è sentito talmente tanto impotente in quel periodo che non sapeva a chi o a cosa aggrapparsi e mi ha indirizzata, inconsapevolmente, nella direzione giusta”.
Fa bene parlarne?
“Sì, fa bene parlarne, ma non sempre e a chiunque. All’inizio non ne parlavo con nessuno, poi ho pensato fosse anche giusto spiegare cosa mi stesse succedendo. Più che altro per ‘giustificare’ le mie assenze e per avere un po’ di conforto. Non sono stata capita, anzi sono stata giudicata in malo modo. Non è bello sentirsi sminuire e sentirsi dare della capricciosa, soprattutto se sai quanto ti sia costato aprirti. Quindi sì, fa bene parlarne con chi vuole ascoltare, con chi sa mettersi nei panni di un altro".
Chi ti ha capita di più?
“Non per forza gli amici di una vita. Ho trovato più comprensione in persone che conoscevo da poco ma con cui c’è stata subito complicità. Ho trovato più conforto in uno sguardo regalatomi da un conoscente che in frasi dette dagli ‘amici’. Ho trovato più gentilezza ed empatia da persone che vedevo una volta al mese, rispetto a chi vedevo 5 giorni a settimana”.
Prova a spiegare cosa sono l’ansia e il panico a chi non ne soffre?
“Credo sia impossibile da spiegare e impossibile da comprendere se non lo provi sulla tua pelle. A volte è difficile anche spiegarlo a me stessa. Quando sto bene, sono spensierata e felice, mi domando: ma perché poi torna? Ma perché non riesco a cacciarla per sempre? Ma perché, se riesco a stare così bene, poi deve riaprirsi quel maledetto cassetto e riportarmi giù nell’abisso dell’ansia?”.
Sono un qualcosa di più nella vita rispetto agli altri o un qualcosa di cui ti libereresti subito?
“Ovviamente me ne libererei subito. Non vorrei essere così, chi vorrebbe essere costantemente sul punto di star male? Chi lo sceglierebbe? Certo, sono fiera del percorso che ho fatto e sto facendo: ho imparato tantissime cose e sono una persona nuova. So però che quest’ansia come sottofondo della mia vita ci sarà sempre: se potessi scegliere me ne libererei subito”.
Cosa consigli a chi ne soffre come te?
“Consiglio di farsi aiutare da un professionista. Consiglio di rinunciare a qualcosa, che sia in termini di denaro o di tempo, e di chiedere aiuto. Consiglio di non abbattersi se non si riesce a trovare un terapeuta adatto alla propria persona e alle proprie esigenze, continuate a cercare chi può aiutarvi. Consiglio di non vergognarsi, di non chiudersi a riccio, di non isolarsi”.
E a chi vive accanto a chi ne soffre?
“A chi è accanto ad una persona che soffre di ansia e attacchi di panico consiglio di farla riflettere sulla possibilità di andare in terapia. Poi consiglio di non strafare. Non sempre parlare è la soluzione migliore, non sempre uscire e distrarsi è la cosa migliore da fare. A volte una persona che soffre d’ansia ha solo bisogno di un abbraccio, un sorriso e silenzio. Molto spesso dopo un attacco di panico ci si sente debilitati e stanchi. Star vicino ad una persona vuol dire anche sedersi di fianco a lei e lasciarla piangere mentre si guarda un film. Non domandate sempre: vuoi parlare? stai bene? com’è andata oggi? Cercate di trasmettere a questa persona che ci siete, sempre, ma non assillatela. Sapere che c’è qualcuno che ci ascolta o ci abbraccia è già una grande cosa. Poi c’è una cosa che non sopporto, da non fare mai”.
Quale?
“Chiedere sempre ‘perché?’. Perché hai avuto un attacco di panico? ‘Non lo so’. Perché oggi ti è capitato e ieri no, visto che hai fatto la stessa cosa? ‘Ma che domanda del cazzo! Nuovamente, non lo so!”. Perché non riesci a stare tranquilla? ‘Per l’ennesima volta, non lo so… Ma se tu lo sai fammi un fischio’. Perché te le vai a cercare? ‘Cosa mi cerco? L’ansia? Sono masochista?’. Insomma, cercate di far capire che ci siete ma non tartassate la persona che non sta bene. A volte basta solo far entrare un po' di luce".
Il link all’articolo originale è:
Intervista delle Iene ad una ragazza che soffre di ansia e attacchi di panico
G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo